
Quando si dice “mandare tutto a puttane” probabilmente ci si riferisce alla mia capacità organizzativa. Che è quella di un seienne sotto mdma. O alla mia capacità di gestione dei rapporti, che è guidata dalla razionalità di una ragazzina di dodici anni che sta per avere il suo primo ciclo mestruale.
Tutto questo ben nascosto da una maschera di impassibilita che farebbe invidia ad un giocatore di poker.
Ho gli occhi a specchio, in grado di nascondere quasi tutte le emozioni.
Tranne in un caso che non starò qui a spiegare. Così come c’è solo un caso al mondo, nel mio mondo privato, in cui non sono in grado di trattenere la voglia ed il bisogno di telefonare e scrivere messaggi.
Ma questa è, decisamente, un’altra storia.
Fa caldo, il cielo è azzurro e terso, la Madonna è sempre lì ad osservare la strada, e la musica mi tiene compagnia.
Ho deciso di passare al tabacco, visto che le sigarette sono aumentate ancora ed io ho aumentato esponenzialmente il consumo di queste ultime.
Da quando ho smesso di fumare erba e fumo.
Ci si disintossica dal veleno solo tramite altro veleno.
O almeno, io ho sempre fatto così.
Non è la giusta maniera, indubbiamente, ma la risposta, la mia risposta a tutte le domande è sti cazzi, e non quarantadue.
In questo io e Douglas Adams non siamo mai andati d’accordo.
Fa caldo, il cielo è terso e azzurro, la musica mi tiene compagnia ed io aspetto la fine del mondo.
Con la serenità che contraddistingue il fumatore di oppio, e placido come una vacca indù.
L’orizzonte si riempirà di fiamme violacee virate al rosa, tutti crederanno ad un meraviglioso tramonto sulla capitale, invece sarà l’Omega che verrà a prendersi il suo spazio ed il suo tempo.
Chiamami quando sarai pronta ad essere reale Madonna nera. Hallelujah.
Mentre tutti correranno all’impazzata urlando in preda ad un panico animale, mi limiterò a versare un bicchiere e brindare ad un orizzonte che si assottiglia fino a scomparire, inglobando tutto.
Perché è così che deve andare, perché è così che è scritto nel grande libro del destino, quello che ho iniziato a leggere dall’ultima pagina, non per curiosità, solo per dispetto.
Per fare dispetto a quel dio a cui non credo pur nominandolo spesso.
Per vedere se davvero l’assassino è il maggiordomo o la scimmia coi piattini da suonare una volta caricata a molla.
E sarà un sabato qualunque, un sabato italiano, fatto di colline che in lontananza si vedono e poi scompaiono dietro una coltre di nubi grigiastre.
Nessuno da avvertire se stasera non torni a casa, nessuno a cui dire faccio tardi non aspettarmi, nessuno a cui chiedere che fine hai fatto. Nessuno da incolpare per quel palo d’ulivo arroventato e piantato nell’occhio del ciclope.
La città trattiene il fiato mentre i vessilli si scontrano nell’arena, il colore del cuore e del sole contro quelli del cielo, ma solo a certi orari.
Gli stessi colori del cuore e del sole si prendono il cielo quasi tutte le sere, e le aquile tornano nei loro nidi a leccarsi le ferite.
Di tutto questo mi interessa relativamente.
Solo una piccola parte di ciò che fui è rimasta qui dentro a tenermi compagnia, tutto il resto è andato via, lontano come lontane sono le stelle ed i ricordi dei sogni vaghi al mattino.
Ballavamo un tango lungo un marciapiedi,
Lei era molto più bassa di me, e c’era un’allegria nell’aria calda di fine giornata.
Un procione faceva capriole sui paletti anti parcheggio, e si sdraiava sulle foglie gialle trascinate dal vento. Un muso brutto e rovinato, un’espressione aggressiva.
Il cielo scoloriva piano, gli alberi ed il fiume di sfondo.
Eravamo giovani e pieni di speranze, pieni di possibilità che non avremmo colto mai, ma nei nostri occhi c’era ancora la speranza, una speranza anni novanta che il mondo avesse un posto per noi.
Un bacio dolce e le campane, la voce al megafono ed il telefono che inizia a suonare, trascinandomi di nuovo qui, trent’anni dopo, in questa realtà che non capisco più. In questa vita da sveglio che ha il sapore del ferro. E l’espressione cattiva di un procione malato e pieno di parassiti.
Una caricatura come quelle che disegnavo ossessivamente da giovane. Quando ancora mi perdevo su fogli bianchi fino a consumare i pennarelli e i polpastrelli.
Fino a liberare la testa da tutti i mostri che la abitano.
«Qui un uomo aveva tana, un mostro,
Che greggi pasceva, solo, in disparte,
E non si mischiava,
Ma solo viveva, aveva animo ingiusto.
Era un mostro gigante; e non somigliava
A un uomo mangiator di pane, ma a picco selvoso
D’eccelsi monti, che appare isolato dagli altri.»

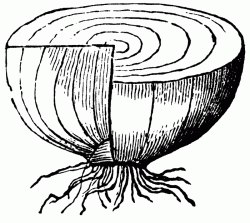






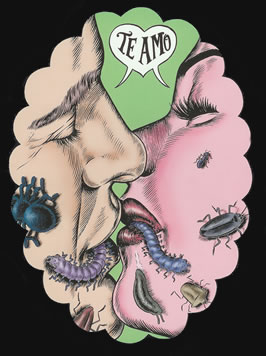

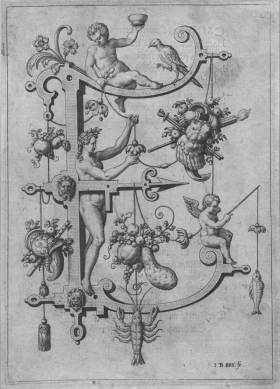

Lascia un commento